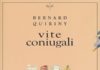Colson Whitehead è autore di libri importanti, di libri che si spingono nell’interrogazione della storia americana con l’ostinato intento di portarne alla luce vergogne e brutture. Il suo sguardo sulla storia è arrivato potente a noi grazie a La ferrovia sotterranea, libro che raccontava l’orrore senza speranza della Georgia ottocentesca e la storia di due schiavi neri, Cora e Caesar, colti nello svolgersi della loro disperata fuga verso la libertà. Il libro, vincitore tra gli altri del prestigioso premio Pulitzer, ha riscosso un notevole successo internazionale ed ha lasciato il passo all’attesa per il nuovo romanzo dello scrittore statunitense, uscito per Mondadori nello scorso settembre.

I ragazzi della Nickel è la storia di un luogo maledetto, quella Nickel Academy che altro non è se non una discesa agli Inferi per tutti i ragazzi a cui viene negato il privilegio di una vita solo normale: «svantaggiati e azzoppati ancora prima che la gara cominciasse, senza poter capire come essere normali». Siamo agli inizi degli anni Sessanta, l’America del Sud comincia ad essere percorsa, pure nelle sue remote periferie, dai sempre più decisi fremiti della comunità afroamericana e la magica voce del Dottor King scalda il cuore del giovane Elwood: studente modello, ragazzo abituato al lavoro e retto da un’etica incrollabile, si ritrova per assurdo accidente a dover sospendere ogni sogno per scontrarsi con la dura realtà della scuola-riformatorio. Per nulla scuola invero, e piuttosto luogo in cui la crudeltà viene amplificata e raffinata «aprendogli gli occhi sulle lunghezze d’onda più cupe» e dove di notte «gli unici rumori erano lacrime e insetti, e potevi dormire in una stanza stipata di sessanta ragazzi eppure sentirti l’unica persona sulla Terra». Whitehead racconta di ragazzi che per tutta la vita si sentiranno sempre in fuga, anche fuori dalla Nickel (e uscirne non è cosa sempre scontata), scoperchiando il vaso delle atrocità commesse all’interno dell’istituto di correzione (per le quali si è ispirato ad una vicenda realmente accaduta in Florida) e, più in generale, la miseria della segregazione razziale in America. Elwood, e i ragazzi come lui, sopravvivono soltanto grazie alla loro capacità di sopportazione («ci respiravano dentro, ci mangiavano dentro, ci sognavano dentro»); sorbiscono la quotidiana porzione di infelicità come «per entrare in sé stessi – giù nella caverna, per poi tornare alla luce con ciò che avevano trovato». Ed è allora che la scelta diventa ineludibile («Questo o questo. Questo mondo le cui ingiustizie ti hanno reso docile ed evasivo, oppure questo mondo più vero che aspetta che tu lo raggiunga?») e la chiamata all’azione impellente: per misurare la propria distanza dal mondo servirà spalancare le braccia, «le mani protese come per saggiare la solidità delle pareti di un lungo corridoio che stava percorrendo da molto tempo e di cui non si vedeva la fine».
Diana A. Politano